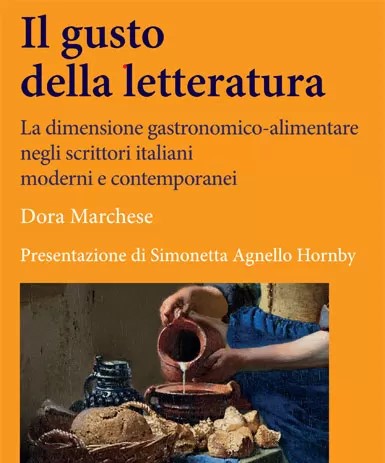Così scrive Dora Marchese nelle parole introduttive al suo studio a proposito di quelle che chiama “Le sapide lettere”. Partendo dall’analisi di opere e momenti salienti della nostra letteratura, il libro, edito da Carocci, individua funzioni e usi della rappresentazione del cibo nel romanzo, nel teatro e nel cinema.
Il percorso prende avvio dal periodo risorgimentale, con i caffè e le osterie – cruciali luoghi d’incontro di uomini e idee – , con le sue rivoluzioni e i suoi eroi: Garibaldi, Cavour, Vittorio Emanuele III, ma anche Pellegrino Artusi che ha influenzato capolavori come Pinocchio e I promessi sposi.
Prosegue poi con narratori anagraficamente vicini – a cavallo tra Ottocento e Novecento – ma stilisticamente molto lontani tra loro, come Giovanni Verga, Gabriele d’Annunzio e Luigi Pirandello – arrivando a Filippo Tommaso Marinetti e al futurismo, dove la cucina sembra diventare sintesi di un’esperienza artistica totalizzante.
Approdando al secondo Novecento l’analisi di Marchese si concentra sui siciliani Tomasi di Lampedusa (con un’incursione nel cinema di Luchino Visconti), Elio Vittorini, Vitaliano Brancati, per concludere infine il suo excusus con il “visionario” Italo Calvino e il “pluristilista” Carlo Emilio Gadda.
In questa lunga e documentata cavalcata ciascuno ritrova pagine già lette e può rivisitarle con occhi nuovi scoprendo il modo di rappresentare e interpretare il cibo e la tavola proprio dei diversi autori.
Ci limiteremo qui a due esempi: il romanzo “Il gattopardo” di Tomasi di Lampedusa con la straordinaria trasposizione cinematografica del regista Luchino Visconti e lo stile narrativo di uno straordinario innovatore come Carlo Emilio Gadda.
Ma veniamo al secondo esempio, vale a dire al cibo nella scrittura di Gadda.
“Autore di una produzione letteraria densa e composita dal punto di vista sia linguistico che tematico, Carlo Emilio Gadda – spiega Marchese – era amante della buona tavola, e i suoi scritti abbondano di brani in cui cibi, bevande ed elaborate ricette rivestono un importante significato che va dal realistico/connotativo al paradossale, non disdegnando aperture dal grottesco al dissacrante, dal simbolico al surreale. […] Tensione onnivora e cupidigia vitale intridono le pagine degli scritti di Gadda, concretandosi nell’uso di registri linguistici vari (lingue, dialetti, gerghi, tecnicismi, neologismi), di modalità e tecniche gastronomiche altrettanto varie (cucina milanese, toscana, romana, meridionale).
E a proposito di Gadda il libro cita proprio quella ricetta del risotto alla milanese – lo scrittore lo chiama risotto patrio – che cucinadigusto aveva già proposto ai suoi lettori e che venne presa ad esempio dallo stesso Italo Calvino, come spiega Marchese.